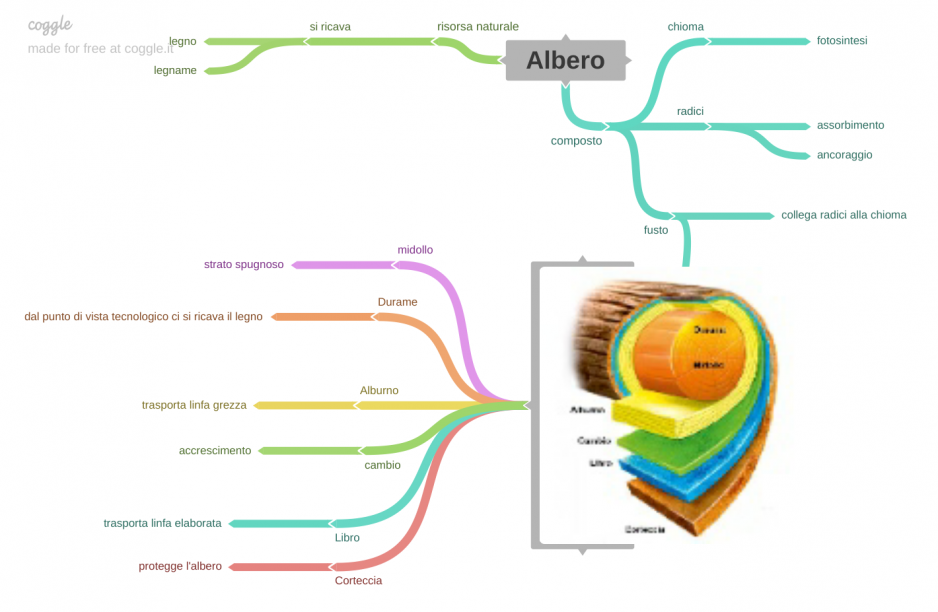Il carbone è una particolare roccia sedimentaria di colore bruno o nero, formata da due gruppi di sostanze:
- materiale organico, cioè carbonio con piccole parti di idrogeno e ossigeno, che con la combustione fornisce calore (energia termica) e anidride carbonica;
materiale inorganico cioè argille, sali di zolfo, che con la loro combustione danno origine alle ceneri e alle sostanze inquinanti.
Come si è formato? Questo combustibile deriva dalla carbonizzazione di intere foreste (carbogenesi), iniziata molti milioni di anni fa ed ha richiesto tre fasi principali:
- crescita di grandi e fitte foreste in presenza di un clima umido;
- sprofondamento lento del terreno e copertura degli alberi da parte delle acque e dei fanghi portati dai fiumi; successivamente si trasformano in roccia che comprime la massa vegetale;
- carbonizzazione dovuta ai batteri che in milioni di anni hanno divorato l’idrogeno e l’ossigeno del legno ed alla fine resta il carbonio con piccole quantità di altri elementi.

Ricapitolando. I carboni fossili sono di origine vegetale e derivano da grandi distese di foreste che, centinaia di milioni di anni fa, sono sprofondate e sono state ricoperte dalle acque e, poi, sepolte sotto una spessa coltre di argilla ed altri materiali. La lenta e graduale decomposizione di queste enormi quantità di legname, avvenuta in assenza di aria, in presenza di batteri anaerobi e sotto l’azione di grandi pressioni ed alte temperature, ha generato un processo di trasformazione chiamato carbonizzazione. I tessuti vegetali, che sono costituiti prevalentemente di cellulosa (costituita da idrogeno e ossigeno), durante il processo di carbonizzazione hanno perso gradualmente l’idrogeno e l’ossigeno. Al termine della trasformazione è rimasto solo il carbonio.
I grandi sconvolgimenti geologici che causarono l’inizio di questi grandi fenomeni di trasformazione avvennero in diverse Ere, quindi i carboni fossili che estraiamo hanno età diverse e sono di vario tipo a seconda della durata del processo di trasformazione subito.
Tra tutti i combustibili fossili, il carbone è quello sfruttato da tempo. Già molto prima dell’invenzione della macchina a vapore, la Gran Bretagna ne usava abbondantemente. Nonostante che i suoi giacimenti siano sfruttati da secoli, si stima che le riserve naturali del nostro pianeta possano soddisfare le richieste ancora per duecento anni. Suo è il merito di aver consentito la Rivoluzione Industriale, fornendo l’energia termica necessaria al motore a vapore. Durante quel periodo (tra l’inizio e la fine del XIX secolo), il consumo mondiale del carbone passò da 20 milioni a 700 milioni di tonnellate annue. Il carbone ha però nella sua natura solida un elemento fortemente negativo: innanzitutto non è adatto ai motori a combustione interna, bisognosi di combustibili fluidi d miscelare con l’aria nella camera di scoppio; secondariamente, presenta maggiori difficoltà di trasporto rispetto al petrolio.
Quest’ultimo, infatti, può essere trasportato su grandi distanze semplicemente per mezzo di un tubo (oleodotto), mentre il carbone va materialmente caricato e scaricato su treni, navi, ecc. A queste difficoltà si aggiunge il notevole potere inquinante dei fumi prodotti da questo combustibile. Tutto ciò ha portato in questi ultimi decenni a preferirgli il petrolio, sicuramente più pratico ed efficiente. Attualmente il consumo di carboni è nuovamente in ascesa, sia per l’eccessivo costo del petrolio greggio sia perché le nuove tecnologie garantiscono maggiore sicurezza durante la fase di movimentazione del carbone, cioè di approvvigionamento e trasporto, durante la fase del suo stoccaggio, cioè di deposito e di immagazzinamento, ed infine, permettono la combustione senza troppi residui nocivi e lo smaltimento delle scorie prodotte nella combustione.
La qualità del carbone dipende dal grado di carbonizzazione che ha subito la massa vegetale, cioè dalla sua età. I carboni più antichi sono molto ricchi di carbonio e quindi hanno un maggiore potere calorifico I vari tipi di carbone si distinguono in base al periodo geologico in cui è iniziato il loro processo di carbonizzazione. Dalla vegetazione marcescente si formò per prima la torba, successivamente l’innalzamento del livello del mare ne causò lo sprofondamento sotto masse enormi di sedimenti marini. Man mano che questi cicli si ripetevano, le torbe di più antica formazione sprofondavano e, sempre più compresse, indurivano, procedendo nel loro processo di carbonizzazione. I carboni più antichi risalgono all’Era Mesozoica, circa 350 milioni di anni fa, i più recenti all’Era Quaternaria, meno di 10 milioni di anni fa.
- Torba: non è un vero carbon fossile, infatti contiene una percentuale di carbonio pari a circa il 60%, perché deriva da piante erbacee lacustri che hanno subito una trasformazione limitata. Ha un aspetto spugnoso o addirittura filamentoso, fibroso ed un colore nerastro. Si trova in giacimenti superficiali (pochi metri di profondità) e in terreni acquitrinosi detti torbiere (giacimenti importanti si trovano in Islanda, Olanda, Germania, ex Unione Sovietica e Finlandia) dove viene estratta con una draga (macchina da scavo). Contiene molta acqua (fino al 70-90%) e viene pertanto essiccata e compressa in mattonelle. Ha un alto contenuto di ceneri e non è un buon combustibile, viene pertanto impiegata soprattutto in agricoltura come concime e come correttivo dei terreni per arricchirlo di humus, come isolante termo-acustico e, grazie al suo elevato potere assorbente e deodorante, come lettiera per il bestiame.

- Lignite: ve ne sono molte varietà, con proprietà diverse. Conserva ancora tracce della struttura fibrosa del legno originario. E’ un carbone abbastanza giovane detto anche brown coal (carbone marrone) e, a differenza della torba che proviene dalla carbonizzazione di erbe palustri, deriva da masse di alberi d’alto fusto di più remota formazione e che hanno subito trasformazioni più profonde rispetto alla torba. Secondo i giacimenti ed il gradi di carbonizzazione vengono distinti diversi tipi di lignite: lignite torbosa (friabile e stratificata); lignite picea (nera, lucida); lignite xiloide (che porta ancora visibile la struttura del legno). La lignite appena estratta contiene il 40% di umidità, che dopo l’essiccamento, si riduce al 15-20%. Può essere utilizzata direttamente o in forma di mattonelle ottenute per semplice compressione. Questo carbone, che contiene una percentuale di carbonio pari a circa il 75%, non è un buon combustibile e poiché non conviene affrontare le spese di trasporto, viene utilizzato sul posto per alimentare centrali termoelettriche o come materia prima per alcune industrie chimiche. Giacimenti importanti si trovano in ex Unione Sovietica, Germania, Inghilterra e Romania. In Italia se ne trovano piccole quantità in Toscana, Umbria, Sardegna e Calabria.

- Litantrace: è il carbon fossile che trova maggiore utilizzazione nell’industria. E’ di colore scuro opaco o poco lucente, di formazione più antica della lignite e più recente dell’antracite. La sua formazione risale al periodo carbonifero, cioè a circa 300 milioni di anni fa. Contiene una percentuale di carbonio pari a circa il 93% e una percentuale di zolfo molto bassa e talvolta nulla. Per la sua composizione, che permette gli usi più svariati, e per la vastità dei giacimenti, è il più importante dei carboni fossili. Dal litantrace riscaldato ad elevate temperature (1000°C) in assenza di aria, si ricava il coke metallurgico. Quest’ultimo viene utilizzato negli altiforni per la produzione di acciaio.

- Antracite: è il più antico dei carboni fossili e rappresenta il prodotto di un avanzatissimo stadio di carbonizzazione dei vegetali. Ha un aspetto metallico, nero, lucente e compatto e brucia lentamente non lasciando alcun residuo durante la combustione. Contiene una altissima percentuale di carbonio (circa il 95%) e conseguentemente bassi tenori di ceneri e di sostanze volatili. Per il suo notevole potere calorifico è uno tra i migliori combustibili . Ideale per il riscaldamento, non trova grandi applicazioni industriali perché si preferisce il meno costoso litantrace. Si trova in terreni geologicamente molto antichi (Era primaria) ed è abbondante in varie località della Francia, della Svizzera, della ex Unione Sovietica e negli USA. In Italia piccoli giacimenti si trovano in Val d’Aosta, in Piemonte (provincia di Cuneo) e nelle Alpi Liguri, in Sardegna.

A partire dal XVI secolo, in particolare in Inghilterra, per risolvere il problema dell’approvvigionamento energetico degli impianti siderurgici, si comincia a sostituire il carbone di legna con quello fossile. Le prime miniere di carbone erano pozzi verticali, profondi circa 10 metri. Il carbone veniva tagliato e portato in superficie all’interno di cesti. Man mano che i pozzi diventavano più profondi e si scavavano gallerie laterali sempre più lunghe, aumentava la possibilità di frane, allagamenti, esplosioni causate dalla presenza di gas metano. Oggi i giacimenti di carbone sono ampiamente diffusi in tutto il mondo e Cina, ex URSS e USA sono i maggiori produttori a livello mondiale. Il ciclo del carbone comprende la coltivazione mineraria, il trasporto e la distribuzione, la combustione diretta o la conversione in prodotti vari, liquidi e gassosi. I giacimenti si trovano più comunemente in profondità, ma possono anche affiorare al livello del suolo. Il loro sfruttamento si può effettuare in due diversi modi:
- coltivazione a cielo aperto dove l’estrazione viene effettuata in aree in cui il giacimento di carbone è molto vasto, si trova vicino alla superficie ed il carbone è facilmente rimovibile. La crosta rocciosa viene sbancata e con attrezzature speciali si rompe il carbone separandone grandi quantità in maniera rapida ed economica. Questo sistema è dannoso dal punto di vista ambientale in quanto si crea un grosso scavo nel terreno e si solleva molta polvere nera che viene sparsa dai venti per decine di chilometri. Esaurita la miniera, la società mineraria deve provvedere a sistemare lo scavo, ristabilendo le condizioni iniziali.
- Coltivazione sotterranea: in questo caso vengono utilizzati diversi tipi di accesso alle vie sotterranee, i pozzi verticali (che permettono l’accesso alle gallerie e che sono attrezzati con impianti di sollevamento) e gallerie inclinate o gallerie orizzontali (a diverse profondità e quindi disposte a livelli diversi, seguendo i filoni carboniferi) in quanto la profondità delle miniere può superare i 1.000 metri. In questo caso, l’unico cambiamento nel paesaggio sono le montagne di rocce sterili che si formano in prossimità dei pozzi, invece sono alti i rischi per i minatori e per ridurre tali rischi si adottano numerose norme di sicurezza: le gallerie potrebbero franare e quindi vanno puntellate con centinature metalliche; l’acqua delle falde potrebbe allagare le gallerie e quindi viene sollevata in superficie con pompe; l’aria può circolare per tiraggio naturale, ma se le gallerie sono molto profonde si devono usare sistemi di aria forzata; il gas metano o grisou è spesso presente in sacche e potrebbe invadere le gallerie quando si abbatte una parete; per evitare le esplosioni si usano macchine ad aria compressa che non producono scintille. La salute del minatore è comunque esposta ad alti pericoli: le polveri respirate possono provocare la silicosi; il rumore delle perforatrici causa disturbi all’udito; l’aria sottoterra è calda e presenta molta umidità.